Piero Buscaroli
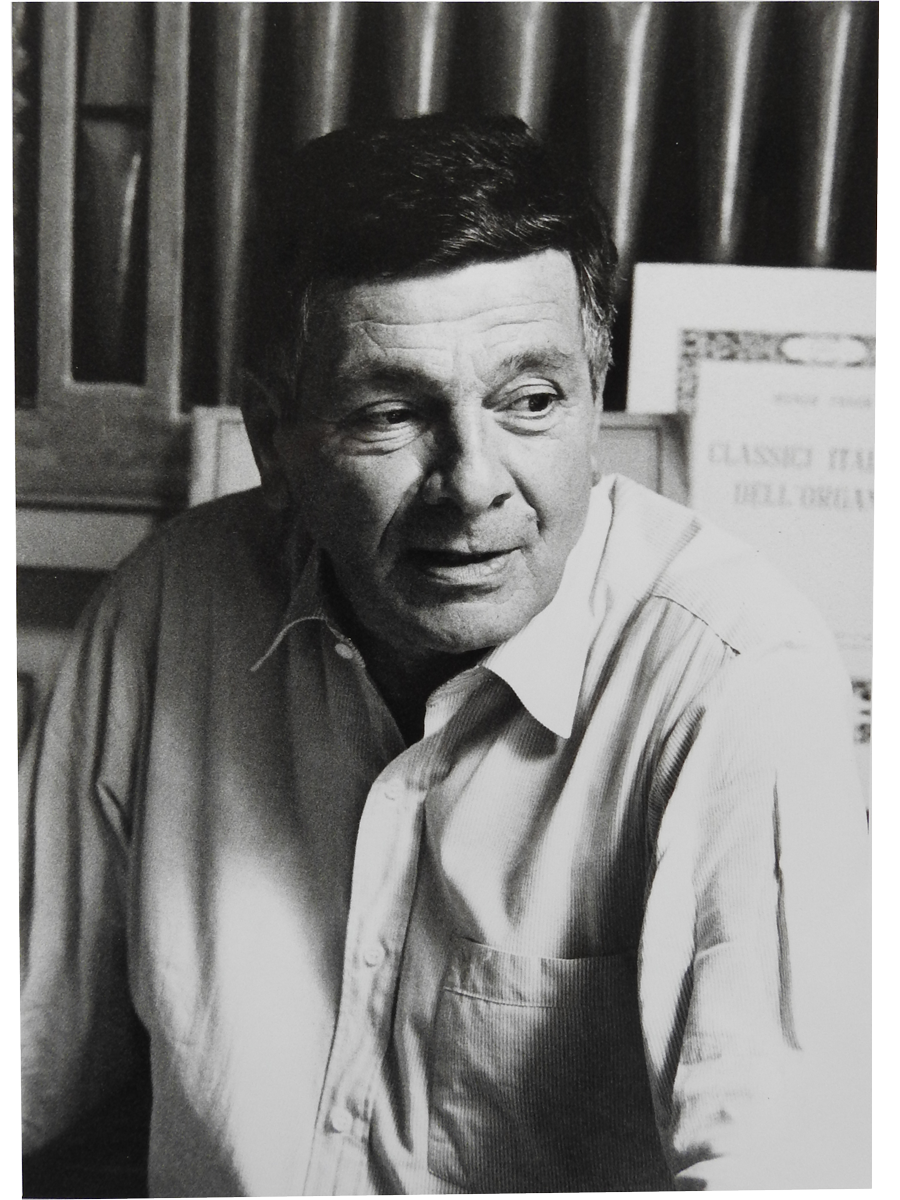
Piero Buscaroli (Imola, 21.VIII.1930 – Bologna, 15.II.2016) giornalista, musicologo, critico musicale e storico.
Nacque da Anna Falorsi, insegnante d’inglese di antica famiglia fiorentina, e da Corso, imolese, latinista e fondatore del Liceo classico di Imola “Benvenuto Rambaldi”.
Nel 1945 Piero Buscaroli si trasferì a Roma con la madre e frequentò il Liceo “Torquato Tasso”; per poi fare ritorno a Bologna, dove si laureò in Storia del diritto italiano con Giuseppe De Vergottini. Intraprese gli studi musicali giovanissimo, alla guida della pianista imolese Maria Baroncini, per poi proseguirli con Ireneo Fuser, organista e compositore, insegnante al Conservatorio di Bologna per oltre quarant’anni, da cui apprese anche i primi rudimenti dell’armonia e del contrappunto (poi approfonditi in solitudine). Chiamato al «Borghese» da Leo Longanesi, vi rimase con Mario Tedeschi dividendo l’impegno giornalistico tra la politica internazionale (fu inviato di guerra in Palestina, Vietnam, Praga) e la musica, a cui approdò quando il settimanale ebbe bisogno di un critico musicale. Adottò lo pseudonimo di Hans Sachs, poeta e drammaturgo tedesco vissuto a Norimberga nel ’500 a cui Wagner dedicherà l’opera Die Meistersinger von Nürnberg. «Non volevo fare il critico», confessò Buscaroli alla premessa della seconda edizione della Stanza della Musica, «perché sapevo troppo bene i miei limiti, di conoscenza e di atteggiamento», aggiungendo che, nell’universo vasto della musica, non riusciva ad amare tutto. Così si definì un “irregolare”, come irregolare era stata una formazione che l’aveva portato ad appropriarsi dello studio dell’armonia come del tedesco e del tedesco antico da autodidatta.
Già nella Stanza della Musica, che comparve l’anno stesso in cui Buscaroli divenne insegnante di Storia della Musica in Conservatorio, l’autore si misurò con le Passioni di Bach, il Fidelio e la Missa Solemnis di Beethoven, la Messa in do min. di Mozart e le Sinfonie di Bruckner: tutti argomenti che, una volta entrati nel suo pensiero, mai più ne uscirono, restando per anni il centro del suo interesse musicale.
Dal 1972 al 1975 diresse il quotidiano «Roma» di Napoli, mentre nel 1979 iniziò una nuova collaborazione con «Il Giornale» di Indro Montanelli. Per molti anni scrisse articoli di costume e politica, firmandosi con lo pseudonimo “Piero Santerno” (Santerno è il fiume che lambisce Imola), prima di diventare critico musicale del quotidiano milanese.
Nel 1982 Rusconi pubblicò il primo studio di critica musicale, La nuova immagine di J. S. Bach, che, destinato dapprima a introdurre l’edizione italiana del libro di Karl Geiringer (I Bach. Storia di una dinastia musicale, Rusconi, 1981; un volume della collana “Musica e Storia” allora diretta da Buscaroli e Paolo Isotta), divenne poi un saggio a sé stante, viste la mole di problemi che la ricerca bachiana poneva e le «novità di conclusioni tuttora insospettate dal lettore musicale, anche colto e aggiornato, in Italia e fuori d’Italia». La nuova immagine di Bach prendeva le mosse da un celebre scritto di Friedrich Blume apparso nel Neues Bach-Bild presentato al Bachfest di Magonza e definito dallo stesso autore, celebre musicologo tedesco (1893-1975), un «terremoto». Come scrisse Paolo Isotta recensendo il volume: «Buscaroli agisce su tre fronti; quello dell’indagine psicologica, quello della nuova interpretazione di documenti di lunga data e quello delle conclusioni ch’egli, con Blume, trae dalla nuova cronologia» (il «Corriere della Sera», 17 maggio 1982).
Il monumentale Bach, frutto di questa profonda immersione nella verità e nella storiografia corrotte da secoli di negligenza, vide la luce quattro anni dopo, 1985, per Mondadori. Un nuovo Johann Sebastian Bach usciva da una monografia di 1200 pagine, tesa a cambiare il volto del Kantor (anche in senso reale perché la copertina della prima edizione reca un ritratto a pastello oggi in collezione ignota che il figlio Carl Philipp Emanuel giudicò un «bel pastello, molto somigliante»).
Il libro ebbe innumerevoli riedizioni, fino a diventare un “Oscar”, ossia un’opera accessibile a un pubblico più vasto. L’ultima edizione del Bach uscì postuma nel 2017, sempre nella collana mondadoriana degli Oscar. In una polemica e tagliente prefazione alla terza edizione, Buscaroli rievocò la situazione delle ricerche bachiane, sottolineando la decisa difficoltà a recepire le novità del suo lavoro, in Italia ma ancor più in Germania. Nel corso dell’immane lavoro sul compositore di Lipsia, Buscaroli pubblicò la voce su Arcangelo Corelli per il Dizionario Biografico degli Italiani (1983): si trattava di un autore sempre amato e, ancora una volta, a suo dire, mal capito dai contemporanei e dai posteri.
In questi anni, dal 1976 al 1994, insegnò Storia della Musica presso i Conservatori di Torino, Venezia, Cesena, Parma e Bologna.
Lo stesso risultato di «una spremitura, talvolta poliziesca, dei documenti» portava intanto Buscaroli a un altro “caso” complesso e controverso, lo studio del Requiem di Mozart e del rapporto dell’autore con l’imperatore Giuseppe II. La morte di Mozart (pubblicato da Rizzoli nel 2002) affronta ancora un’ardua scalata di documenti, lettere, testimonianze, verità e bugie; che doveva terminare con un veloce e quasi romanzesco libretto edito da Marietti alcuni anni dopo, Al servizio dell’imperatore (2006). Di Buscaroli è stato detto che “intende collocarsi nella corrente del revisionismo storiografico, estendendola dal campo politico a quello musicale”. Nel volume su Rizzoli e in quello di Marietti che ne è una sorta di epilogo Buscaroli avanza e ribadisce l’ipotesi che il Requiem di Mozart sia rimasto incompiuto non, come vuole la tradizione, a causa della morte del suo autore, bensì per una scelta deliberata di Mozart stesso, dovuta alla sua ripugnanza ad adempiere la clausola contrattuale (impostagli dal committente) che gli impediva di rivendicare la paternità della sua opera. Secondo lo studioso, Mozart avrebbe ritenuto tale clausola talmente vessatoria da indurlo a non completare la partitura, e forse addirittura a meditarne la distruzione.
Buscaroli spesso dichiarava ad amici, allievi, a noi famigliari, che, dall’infanzia, non aveva passato giorno della sua vita senza pensare a Beethoven. Il migliore amico della giovinezza imolese, Pier Giorgio Sabbatani, gli aveva svelato i tesori delle sonate per pianoforte. E dunque, preparate dal volto indomito e pensoso che derivava dalla statua di Max Klinger oggi al Gewandhaus di Lipsia, giunsero sui tavoli dei teorici, dei critici, dei musicisti altre 1350 pagine, sotto il titolo di Beethoven (Rizzoli, 2002; poi Mondadori 2019).
In quegli anni, Buscaroli lavorò molto per i teatri, in primis per il Comunale di Bologna, dove commemorò Johannes Brahms nel centenario della morte (1997), per poi dare vita, con l’entusiasmo del sovrintendente Carlo Fontana, al ciclo completo delle sinfonie di Anton Bruckner (Immagine di Bruckner, secondi anni ’80), nei cui libretti di sala – ora riordinati in un libro – stese una sorta di biografia. In quegli anni Buscaroli si concentrò sulla ricostruzione di una autobiografia.
Nel 1988 scrisse un corposo testo sulla Clemenza di Tito, poi, nel 1992, Il contrappunto della memoria, prefazione alla Götterdämmerung di Wagner diretta da Riccardo Chailly.
Pubblicazioni:
- La Stanza della musica, cronache e pretesti da un decennio, Torino, Fògola, 1976;
- La nuova immagine di J. S. Bach, Milano, Rusconi, 1982;
- Tra fenomeno e leggenda, prefazione a Il fenomeno Wagner, a cura di Dario Della Porta, Torino, Fògola, 1983, pp. VII-XIV;
- Bach, Milano, Mondadori, 1985 (varie ristampe nella collana Oscar Mondadori, l’ultima Mondadori Oscar Baobab, 2017);
- Il Parnaso e l’Olimpo del genio di Mozart, in La clemenza di Tito, Bologna, Teatro Comunale, 1988, pp. 14-75;
- La morte di Mozart, Milano, Rizzoli, 2002;
- Al servizio dell’Imperatore. Come Giuseppe II spinse Mozart alla rovina, Torino, Marietti, 2006;
- Gabriel Musico maestro di simboli, labirinti & terremoti: ricognizioni in d’Annunzio, Varese, Zecchini, 2007;
- Beethoven, Milano, Rizzoli, 2004, ristampa Milano, Oscar Baobab, 2019;
- L’immagine di Bruckner, a cura di Carlo Fontana e Luigi Ferrari, 2021.
Beatrice Buscaroli
Sito ufficiale: https://pierobuscaroli.it
Verso Bach e Mozart
Giornalista, saggista d’arte e storico, Piero Buscaroli nacque a Imola il 21 agosto 1930, da Anna Falorsi, insegnante d'inglese di antica famiglia fiorentina, e da Corso Buscaroli, imolese, latinista e fondatore del Liceo classico di Imola “Benvenuto Rambaldi”. Studioso di Persio, Orazio, Virgilio, Corso Buscaroli tradusse il IV Canto dell’Eneide, dedicando al testo un ampio volume pubblicato dalla Società Anonima Editrice Dante Alighieri nel 1932: Il libro di Didone, Testo con traduzione a fronte seguito da ampio commento interpretativo ed estetico. Inoltre tradusse il Satyricon di Petronio e delle Liriche in “versioni poetiche” di Heine e Goethe.
Nel 1945 Piero Buscaroli si trasferì a Roma con la madre e frequentò il Liceo “Torquato Tasso”; per poi fare ritorno a Bologna, dove si laureò in Storia del diritto italiano con Giuseppe De Vergottini. Intraprese gli studi musicali giovanissimo, alla guida della pianista imolese Maria Baroncini, per poi proseguirli con Ireneo Fuser, organista e compositore, insegnante al Conservatorio di Bologna per oltre quarant’anni, da cui apprese anche i primi rudimenti dell’armonia e del contrappunto (poi approfonditi in solitudine).
Chiamato al «Borghese» da Leo Longanesi, vi rimase con Mario Tedeschi dividendo l’impegno giornalistico tra la politica internazionale (fu inviato di guerra in Palestina, Vietnam, Praga) e la musica, a cui approdò quando il settimanale ebbe bisogno di un critico musicale. Adottò lo pseudonimo di Hans Sachs, poeta e drammaturgo tedesco vissuto a Norimberga nel '500 a cui Wagner dedicherà l’opera Die Meistersinger von Nürnberg. “Non volevo fare il critico”, confessò Buscaroli alla premessa della seconda edizione della Stanza della Musica, “perché sapevo troppo bene i miei limiti, di conoscenza e di atteggiamento”, aggiungendo che, nell’universo vasto della musica, non riusciva ad amare tutto. Così si definì un “irregolare”, come irregolare era stata una formazione che l'aveva portato ad appropriarsi dello studio dell’armonia come del tedesco e del tedesco antico da autodidatta.
Già nella Stanza della Musica, che comparve l’anno stesso in cui Buscaroli divenne insegnante di Storia della Musica nei Conservatori di Stato, l’autore si misurò con le Passioni di Bach, il Fidelio e la Missa Solemnis di Beethoven, la Messa in do min. di Mozart e le Sinfonie di Bruckner: tutti argomenti che, una volta entrati nel suo pensiero, mai più ne uscirono, restando per anni il centro del suo interesse musicale.
Dal 1972 al 1975 diresse il quotidiano «Roma» di Napoli, mentre nel 1979 iniziò una nuova collaborazione con «Il Giornale» di Indro Montanelli. Per molti anni scrisse articoli di costume e politica, firmandosi con lo pseudonimo "Piero Santerno” (Santerno è il fiume che lambisce Imola), prima di diventare critico musicale del quotidiano milanese.
Nel 1982 Rusconi pubblicò il primo vero e proprio studio di critica musicale, La nuova immagine di J.S. Bach, che, destinato dapprima come introduzione all’edizione italiana del libro di Karl Geiringer (I Bach. Storia di una dinastia musicale, Rusconi, 1981; un volume della collana “Musica e Storia” allora diretta da Buscaroli e Paolo Isotta), divenne un volume a sé stante, viste l’enormità dei problemi che la ricerca bachiana poneva e le “novità di conclusioni tuttora insospettate dal lettore musicale, anche colto e aggiornato, in Italia e fuori d’Italia”. La nuova immagine di Bach prendeva le mosse da un celebre scritto di Friedrich Blume apparso nel Neues Bach-Bild presentato al Bachfest di Magonza e definito dallo stesso autore, celebre musicologo tedesco (1893-1975), un “terremoto”. Come scrisse Paolo Isotta recensendo il volume: “Buscaroli agisce su tre fronti; quello dell’indagine psicologica, quello della nuova interpretazione di documenti di lunga data e quello delle conclusioni ch’egli, con Blume, trae dalla nuova cronologia” (il «Corriere della Sera», 17 maggio 1982). La novità più eclatante riguardò le tarde Cantate degli anni di Lipsia, quasi tutte “parodie”, ossia rielaborazioni delle opere precedenti, perché Bach, proseguiva Isotta, “teneva il suo personale sentimento religioso ben distinto dalla sua vita professionale”.
Da allora, Buscaroli si dedicò a completare quel che la Nuova immagine aveva introdotto, destinata com'era a mutare completamente l’antica storiografia per effettuare una riscrittura della vicenda umana e musicale del compositore di Lipsia. I documenti originali vennero riletti e tutta la storiografia sei-settecentesca fu riveduta, per riportare alla luce la figura di un uomo dal “carattere potente, irrequieto, in perpetua ebollizione” che scardinava i luoghi comuni dell’aneddotica, e per inserirla nel contesto storico e politico del suo tempo.
Il monumentale Bach, frutto di questa profonda immersione nella verità e nella storiografia corrotte da secoli di negligenza, vide la luce quattro anni dopo, 1985, per Mondadori. Un nuovo Johann Sebastian Bach usciva da una monografia di 1200 pagine, tese a cambiare il volto (anche in senso reale perché la copertina della prima edizione reca un ritratto a pastello oggi in collezione ignota che il figlio Carl Philipp Emanuel giudicò un “bel pastello, molto somigliante”). La Notizia che Buscaroli premise al libro dichiara intenzioni, rischi e dubbi: “Tornare alle fonti e riscrivere la biografia mi parve la sola via da seguire, quando, passando da un’adorazione priva di responsabilità ad una fase attiva di indagine, dovetti riesaminare la non venerabile leggenda”. Davvero “necessario” parve all’autore restituire i veri lineamenti del suo carattere, nonostante “l’ostinazione con cui i libri nuovi perpetuano gli errori dei vecchi”.
Il libro ebbe innumerevoli riedizioni, fino a diventare un “Oscar”, ossia un’opera accessibile a un pubblico più vasto. L’ultima edizione del Bach uscì postuma nel 2017, sempre nella collana mondadoriana degli Oscar. In una polemica e tagliente prefazione alla terza edizione, Buscaroli rievocò la situazione delle ricerche bachiane, sottolineando la decisa difficoltà a recepire le novità del suo lavoro, in Italia ma ancor più in Germania. Nel corso dell’immane lavoro sul compositore di Lipsia, Buscaroli pubblicò la voce su Arcangelo Corelli per il Dizionario Biografico degli Italiani (1983): si trattava di un autore sempre amato e, ancora una volta, a suo dire, mal capito dai contemporanei e dai posteri.
In questi anni, dal 1976 al 1994, insegnò Storia della Musica presso i Conservatori di Torino, Venezia, Cesena, Parma e Bologna.
Lo stesso risultato di “una spremitura, talvolta poliziesca, dei documenti” portava intanto Buscaroli a un altro “caso” complesso e controverso, lo studio del Requiem di Mozart e del rapporto dell'autore con l’imperatore Giuseppe II. La morte di Mozart (pubblicato da Rizzoli nel 2002) affronta ancora un’ardua scalata di documenti, lettere, testimonianze, verità e bugie; che doveva terminare con un veloce, delizioso libretto edito da Marietti alcuni anni dopo, Al servizio dell’imperatore (2006). Di Buscaroli è stato detto che "intende collocarsi nella corrente del revisionismo storiografico, estendendola dal campo politico a quello musicale". Nel volume su Rizzoli e in quello di Marietti che ne è una sorta di epilogo Buscaroli avanza e ribadisce l'ipotesi che il Requiem di Mozart sia rimasto incompiuto non, come vuole la tradizione, a causa della morte del suo autore, bensì per una scelta deliberata di Mozart stesso, dovuta alla sua ripugnanza ad adempiere la clausola contrattuale (impostagli dal committente) che gli impediva di rivendicare la paternità della sua opera. Secondo lo studioso, Mozart avrebbe ritenuto tale clausola talmente vessatoria da indurlo a non completare la partitura, e forse addirittura a meditarne la distruzione. “Mozart è morto mentre la sua fama letteralmente esplodeva come un fenomeno glorioso, mai visto prima nella civiltà germanica”. L’allievo Enrico Raggi così scriveva nel 2006:
«Buscaroli è un maestro. Con tale nome si indicano gli autori di quei rarissimi libri che segnano la vita, che contribuiscono potentemente all’educazione sentimentale, intellettuale e morale di un giovane. Libri capaci di provocare, mediante una scossa radicale, un simultaneo sviluppo dell’intelligenza e del gusto; un’improvvisa eccitazione della nostra più preziosa ma precaria e intermittente facoltà: la facoltà di percepire [...] la costituzione irriducibilmente misteriosa del mondo e della vita».
Beethoven come Michelangelo
Buscaroli spesso dichiarava ad amici, allievi, a noi famigliari, che, dall’infanzia, non aveva passato giorno della sua vita senza pensare a Beethoven. Il migliore amico della giovinezza imolese, Pier Giorgio Sabbatani, gli aveva svelato i tesori delle sonate per pianoforte. E dunque, preparate dal volto indomito e pensoso che derivava dalla statua di Max Klinger oggi al Gewandhaus di Lipsia, giunsero sui tavoli dei teorici, dei critici, dei musicisti altre 1350 pagine, sotto il titolo di Beethoven (Rizzoli, 2002; poi Mondadori 2019). Nella consueta Notizia (una sorta di comunicazione personale e privata al lettore, ché, altrimenti, sarebbe stata semplicemente chiamata “presentazione”), scrive Buscaroli:
«Il libro che presento nacque quale malinconico dovere d’una battaglia di retroguardia: del gigante dovevano restare album, cassette, odiosi cumuli di compact. E invece, nei vent’anni che seguirono quel misero centenario [il 1970], si scatenò imprevisto un paradosso a tal punto immane, che la sua enormità non è ancora ben misurata da quanto avanza della cultura europea [...]. Nella storia delle biografie (“Vi è solo biografia!”, ammonì Nietzsche) cominciai con Sebastian Bach. E intanto Beethoven figlio della Révolution mutava i connotati, via via che la Révolution finiva nelle pattumiere. Per cominciare la galleria dei falsi: Beethoven non fu mai illuminista; non fu mai giacobino; non fu mai amico dei francesi».
Dalla vastità della sua revisione, che toccava storia e religioni, rapporti tra monarchi e musicisti, prese forma l’immensa umanità di un artista che perfettamente si adattava alle forme dell’uomo che ne era padrone. Luoghi, situazioni, rapporti, gerarchie, rientrarono nella visione di un vasto panorama su cui si stagliava la nuova, ulteriore, “nuova immagine”. La storia universale accolse Beethoven come il primo dei musicisti, quale mai era stata. L’apparizione del Beethoven non lasciò riposare le penne dei detrattori che, di fronte a un tale sforzo (lasciando da parte il giudizio sulla ramificata complessità del lavoro), si divertirono a fare qualche battuta; alla quale risposero tuttavia le migliaia di lettori che, ancora oggi, hanno tributato al riedito volume un successo non immaginabile.
Il Beethoven di Buscaroli è insieme il ritratto dell’ultima Europa possibile, e Buscaroli amava accostarne il protagonista a Michelangelo. Molti anni prima, nella Stanza della musica, aveva scritto:
«Le forme dello stile classico, sinfonia, sonata, quartetto, erano costruzioni risultanti dall’equilibrio composto di diverse dinamiche: mai lo spirito di un’età si è trasfuso così inconsapevolmente e così pienamente in una forma artistica nuova come il senso della dialettica hegeliana nelle strutture dello stile classico».
In quegli anni, Buscaroli lavorò molto per i teatri, in primis per il Comunale di Bologna, dove commemorò Johannes Brahms nel centenario della morte (1997), per poi dare vita, con l’entusiasmo del sovrintendente Carlo Fontana, al ciclo completo delle sinfonie di Anton Bruckner (Immagine di Bruckner, secondi anni '80), nei cui libretti di sala stese una sorta di biografia che si cerca di riordinare in un libro. Ma in quegli anni Buscaroli passò all’aspetto biografico della sua vita.
Nel 1988 scrisse un corposo testo sulla Clemenza di Tito, poi, nel 1992, Il contrappunto della memoria, prefazione alla Götterdämmerung di Wagner diretta da Riccardo Chailly. Vorrei ricordare un solo allievo, che, paradossalmente, non era allievo ma giovanissimo collega al Conservatorio di Cesena, Raffaele Di Berto. Un giorno Buscaroli sentì un pianoforte, da cui uscivano le note della sonata op. 111, l'ultima di Beethoven, uno dei cardini della sua passione. Entrò nella stanza dove Di Berto suonava (“senza bussare”, rammenta Di Berto con affettuosa nostalgia). “Da quel momento empatia, ammirazione, amicizia, viaggi, mi hanno legato definitivamente alla sua fonte di sapere inesauribile per tutti noi. Non smetterò mai di celebrarlo”. A proposito delle Variazioni su un valzer di Diabelli op. 120, di poco successive alla sonata op. 111, Buscaroli scrisse:
«E nell’orecchio interno intatto e infallibile gli turbinavano gli ultimi atomi uncinati del trillo. Il trillo implacabile che solo aveva tratto dall’armamentario ornamentale per farne atmosfere e strutture. Bada a quello che fanno con scale e trilli Bach e Beethoven e troverai Michelangelo. Dove struttura e ornamento poetico perdono i confini e si confondono nel non finito: del marmo, che non anela nel rozzo pathos delle incompiute, ma mette in vibrazione “la chiarità che fa l’aere tremare».
La grandezza non era meglio dicibile: Buscaroli rivendicò al Beethoven sordo l’integrità del suono e la riuscita perfetta dell’immagine, della compiutezza. Al che Michelangelo sembra ascoltare e quasi origliare, timido e silente come nell’affresco di Raffaello alla Sistina, acquattato su un avanzo di marmo, assorto in un pensiero lontano, quel che era successo dopo di lui. Quel che era potuto succedere alle arti, tutte insieme.
Piero Buscaroli è mancato a Bologna il 15 febbraio del 2016.
Essenzialmente
Per una bibliografia: La Stanza della musica, cronache e pretesti da un decennio, Torino, Fògola, 1976; La nuova immagine di J.S. Bach, Milano, Rusconi, 1982; Tra fenomeno e leggenda, pref. a Il fenomeno Wagner, a cura di Dario Della Porta, Torino, Fògola, 1983, pp. VII-XIV; Bach, Milano, Mondadori, 1985 (innumerevoli ristampe nella collana Oscar Mondadori, l’ultima Mondadori Oscar Baobab, 2017); Il Parnaso e l'Olimpo del genio di Mozart, in La clemenza di Tito, Bologna, Teatro Comunale, 1988, pp. 14-75; La morte di Mozart, Milano, Rizzoli, 2002; Al servizio dell’Imperatore. Come Giuseppe II spinse Mozart alla rovina, Torino, Marietti, 2006; Gabriel Musico maestro di simboli, labirinti & terremoti: ricognizioni in d’Annunzio, Varese, Zecchini, 2007; Beethoven, Milano, Rizzoli, 2004, rist. Milano, Oscar Baobab, 2019.
Molte presentazioni di opere furono scritte per il Comunale di Bologna, il Comunale di Firenze, la Fenice di Venezia, il Conservatorio di Milano (su Wagner, Rossini, Mozart, Gluck). Innnumerevoli, va da sé, gli articoli di giornale, dentro e fuori la musica.
Beatrice Buscaroli
Le nuove immagini di Piero
in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)
Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio
Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021
